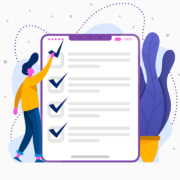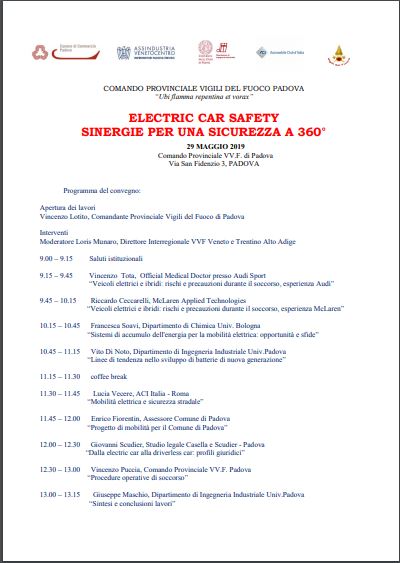I preposti e la vigilanza aziendale: cambia la sicurezza sul lavoro
La recentissima riforma del Decreto 81/08 modifica profondamente le regole della vigilanza aziendale.
Cambiano gli obblighi del preposto, ma soprattutto viene richiesto alle aziende di intervenire sull’organizzazione e sulla formazione, con effetti sugli organigrammi ed anche sui contratti di lavoro. In questa scheda sono approfondite le novità e le misure da adottare.
Continua a leggere l’articolo qui di seguito oppure scaricalo in versione Pdf cliccando qui.
La mini-riforma della sicurezza sul lavoro (Legge n. 215/2021, artt. 13 e 13-bis). La nuova disciplina del preposto.
La legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha convertito in legge il D.L. n. 146/2021, il cui Capo III (artt. 13 e 13-bis) è dedicato a misure per il rafforzamento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In sede di conversione sono state apportate profonde modifiche alla disciplina degli articoli 18, 19, 26 e 37 del Decreto 81/08 in tema di vigilanza e di preposto. Oltre a riscrivere in maniera più netta gli obblighi del preposto, la riforma rafforza la presenza di questa figura nell’organigramma con effetti sull’intero sistema di sicurezza aziendale, sull’assetto dell’attività di vigilanza, sul contenuto dei contratti di lavoro.
***
- La riforma degli artt. 18, 19, 26 e 37: nuove regole per i preposti
La Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 ha modificato, tra gli altri, gli articoli 18, 19, 26 e 37 del Decreto 81/08 in materia di preposto.
E’ una modifica passata un po’ in sordina, forse per il maggior clamore suscitato dalla riforma dell’art. 14 del Decreto 81/08 sulla sospensione dell’attività imprenditoriale e dalla riconfigurazione del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, forse perché sembra contenere soltanto il dettaglio di principi già noti; in realtà le nuove disposizioni, oltre a richiedere un necessario aggiornamento anche formale dei documenti di sicurezza aziendali, lasciano trasparire una nuova prospettiva nell’approccio al tema della vigilanza che potrebbe rivelarsi assai impattante sui tradizionali assetti normativi della sicurezza sul lavoro.
Vediamo innanzitutto le novità.
Art. 18
Nel nuovo art. 18, all’elenco degli obblighi di datore di lavoro e dirigente è stata aggiunta al comma 1 la lettera b-bis), che:
– impone di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19”;
– dispone che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”;
– infine sancisce che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Art. 19
E’ stata riformata la lettera a) dell’art. 19: è confermata la prima parte, secondo cui il preposto deve sovrintendere e vigilare che i lavoratori rispettino le disposizioni ricevute, cambia la seconda parte e cioè l’obbligo di fare che nasce dall’esercizio della vigilanza:
– “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”;
– in via ulteriore, “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
E’ nuova anche la lettera f-bis dell’art. 19: il preposto deve
“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Art. 26
All’articolo 26 viene aggiunto il comma 8-bis:
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Art. 37
Confermato l’obbligo di formazione dei preposti di cui al comma 7, viene aggiunto un nuovo comma 7-ter:
“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
Art. 55
Cambia il quadro sanzionatorio per il datore di lavoro:
la sanzione già prevista dal comma 5 lettera c) per la violazione dell’obbligo di formazione di cui al comma 7 dell’art. 37 viene estesa anche al comma 7-ter;
viene modificato il comma 5 lettera d) introducendo la nuova e diversa sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la quale viene estesa alla violazione dell’obbligo di individuazione del preposto, riferito sia all’art. 18 comma 1 lettera b-bis sia all’art. 26 comma 8-bis.
Art. 56
Infine, anche per il preposto cambiano le sanzioni:
la sanzione del comma 1 lettera a), già prevista per la violazione dell’art. 19 lettera a) rimane confermata, ma ora si applica anche alla violazione della lettera f-bis.
*
Provando a sistematizzare le modifiche, si osserva che il legislatore si è mosso lungo tre direttrici di intervento, poste a diversi livelli.
Una prima direttrice di intervento riguarda il livello operativo e mira a dettagliare il contenuto concreto degli obblighi del preposto con il chiaro obiettivo di renderli più effettivi ed anche più efficaci in termini di risultato. Le altre due direttrici di intervento riguardano la struttura del sistema di sicurezza aziendale: la prima interessa la governance del sistema e la definizione dei ruoli aziendali, e consiste in misure finalizzate a garantire un organigramma rispondente alle esigenze della vigilanza; la seconda interessa il livello organizzativo e mira ad assicurare al preposto, nel momento in cui lo si coinvolge maggiormente, le condizioni per poter svolgere il proprio ruolo.
2. I “nuovi” obblighi del preposto
2.1. La vigilanza sui lavoratori e gli obblighi in caso di “non conformità comportamentali”
La prima parte della nuova lettera a) dell’art. 18 rimane invariata e conferma il primo ed essenziale obbligo del preposto, quello che connota la figura: sovrintendere e vigilare sull’osservanza di obblighi di legge, disposizioni aziendali, uso dei mezzi di protezione e dpi da parte dei singoli lavoratori.
Invece cambia completamente la seconda parte della nuova lettera a), dove il legislatore stabilisce cosa deve accadere quando il preposto accerta situazioni di inosservanza.
Innanzitutto, questo generale concetto di “inosservanza” viene sostituito dalla nuova nozione di “non conformità comportamentale”: formula linguistica che porta direttamente al tema della condotta del lavoratore, da cui il legislatore manifestamente pretende e si attende la “conformità comportamentale”.
Le violazioni riconducibili alla condotta personale del lavoratore vengono in questo modo distinte, e sottoposte ad un diverso regime di vigilanza, rispetto alle violazioni che hanno invece natura tecnico-organizzativa che sono collocate in un’altra e diversa lettera dell’art. 19: la lettera f-bis).
La seconda novità della revisionata lettera a) è che in reazione alla “non conformità comportamentale” il legislatore disegna in capo al preposto una sequenza ben precisa e soprattutto vincolata di obblighi specificamente individuati, cadenzati secondo un predeterminato flusso procedimentale.
Nel previgente sistema, l’obbligo di sovrintendere e vigilare non prevedeva una esplicita azione del preposto verso il lavoratore, ma un obbligo in qualche modo sottinteso: il fatto che l’obbligo di informare i superiori sorgesse in caso di “persistenza” della inosservanza lasciava presupporre un intervento del preposto rimasto senza successo, ma la norma non dettava un obbligo esplicito, e soprattutto non dettava in alcun modo il contenuto dell’azione che il preposto doveva porre in essere.
Ora invece è prescritto un flusso di azioni ben preciso: 1) fornire al lavoratore le indicazioni di sicurezza per modificare il comportamento non conforme; 2) se non basta, interrompere l’attività e 3) informare i superiori diretti.
Il preposto ha dunque l’esplicito obbligo di porre in essere almeno tre azioni correttive, scandite in due diverse fasi: una azione nella prima fase, due azioni nella seconda fase. In questo intervento correttivo si concretizzano a un tempo il “potere gerarchico” che sostanzia la definizione di preposto e la sua funzione di “garanzia”.
La prima azione correttiva è una azione diretta di informazione sulla persona del lavoratore, con la specifica finalità di modificare il comportamento non conforme.
La seconda e la terza azione correttiva vanno compiute se la prima non raggiunge il risultato, e sono da compiere cumulativamente e non in alternativa: l’una è rivolta anch’essa direttamente al lavoratore e consiste nell’interrompere la sua attività; l’altra ha una finalità correttiva nei confronti del sistema, e consiste nell’informare i superiori.
Tutte le azioni correttive sono dovute e non discrezionali (con l’annotazione che anche la lettera f-bis prevede l’interruzione dell’attività, ma solo “se necessario”).
Ciò che appare interessante è che, da un assetto di obblighi così disegnato, sembra potersi desumere un momento in cui la condotta non corretta del lavoratore si trasforma da non conformità comportamentale del singolo in “prassi non corretta”: è il momento in cui il preposto, accertata la non conformità, non dà al lavoratore le informazioni necessarie ovvero, persistendo la non conformità nonostante l’informazione data, egli non interrompe quell’attività e non informa i superiori. La tolleranza o comunque il non intervento del preposto rispetto ad una condotta rilevata, attribuiscono a quella condotta individuale errata del lavoratore, che di per sé potrebbe essere occasionale e non conosciuta, la natura di “prassi aziendale”, intesa come violazione che esce dalla sfera soggettiva del suo autore per entrare in una sfera oggettiva, che è quella del sistema aziendale; entra in gioco infatti quantomeno la sfera di imputabilità anche di altro soggetto, che di quella condotta illecita non è l’autore, ma che rispetto ad essa ha obblighi di garanzia, cioè appunto il preposto.
L’ulteriore adempimento imposto dalla norma, cioè l’informazione ai superiori, a sua volta concorre a rafforzare la natura “aziendale” della prassi scorretta, in un crescendo che conduce, man mano che la conoscenza della non conformità e della sua mancata correzione si diffonde verso l’apice dell’organizzazione, fino al datore di lavoro.
Vero è che la scelta legislativa, di scomporre esplicitamente gli obblighi in diversi livelli di intervento, enfatizza la diversità delle posizioni di garanzia, contraddistinte da livelli diversi di “immediatezza” rispetto alla condotta non conforme e quindi da livelli diversi di potere impeditivo. E’ questo uno degli aspetti della riforma che dovrebbe produrre il maggiore impatto sul regime delle responsabilità, rispetto ad una situazione attuale in cui l’esistenza di comportamenti scorretti viene molto spesso automaticamente imputata al datore di lavoro come omessa vigilanza senza dare attenzione all’esistenza dei livelli gerarchici intermedi. In sostanza, la scansione degli obblighi valorizza anche a livello normativo il tema della “contiguità” della posizione di garanzia rispetto al luogo in cui la violazione è commessa e/o rispetto all’attività lavorativa interessata dalla violazione: tema che è stato oggetto di alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, n. 12137/2021; n. 20833/2019; n. 13838/2015; per il profilo temporale cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 1096/2021) con cui è stata manifestata, da parte della giurisprudenza più attenta, l’esigenza di evitare responsabilità legate alla mera titolarità della posizione di garanzia, anziché ad una effettiva condotta illecita colpevole.
2.2. La vigilanza sui lavoratori e gli obblighi in caso di “deficienze di mezzi, attrezzature, o comunque condizioni di pericolo”
Un diverso aspetto della vigilanza è disciplinato dalla nuova lettera f-bis), e riguarda il caso in cui il preposto rileva deficienze di mezzi, attrezzature, o comunque condizioni di pericolo.
Si tratta di profili di contenuto tecnico-organizzativo, non legati alla condotta non conforme del singolo lavoratore rispetto alle regole ricevute.
In questi casi, l’obbligo del preposto è di interrompere “temporaneamente” l’attività, ma solo “se necessario”, e segnalare le condizioni di pericolo al datore di lavoro e al dirigente.
Qui viene interrotta non l’attività “del lavoratore”, cioè solo del singolo lavoratore che non segue le regole di comportamento insegnate (come nella lettera a): qui si interrompe l’attività in generale, con il che si deve intendere non l’intera attività aziendale, ma quella attività che è interessata dalla deficienza dei mezzi e delle attrezzature, o quella attività che viene svolta in una condizione di pericolo. Potrebbe trattarsi anche qui di una attività di un singolo lavoratore, che ad esempio sta usando una attrezzatura non sicura; ma potrebbe anche trattarsi di una intera linea di lavorazione, e certo potrebbe essere perfino una interruzione totale almeno nei casi più eclatanti.
Il flusso delle azioni del preposto è il seguente: 1) vigilare se ci sono deficienze di mezzi, attrezzature, condizioni di pericolo; 2) se ci sono, valutare se è necessario interrompere l’attività; 3) se sì, interrompere l’attività; 4) in ogni caso, segnalare al datore di lavoro e al dirigente.
La nuova lettera f-bis) è molto simile nei contenuti a quelli di altri obblighi già esistenti e confermati, in particolare quelli della lettera f) e della lettera e), con i quali sarebbe stato probabilmente auspicabile un maggiore coordinamento.
La lettera f), in particolare, è in buona parte sovrapponibile alla nuova lettera f-bis) anche testualmente. La differenza è che la lettera f-bis) riguarda le carenze “rilevate durante la vigilanza” e non (come nella lettera f) “della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”. Il legislatore sembra voler enfatizzare l’importanza della funzione di vigilanza e la sua obbligatorietà, rispetto ad una più generica “conoscenza”; comunque la nuova formula sembra comprendere la vecchia, perché rilevare le carenze include ovviamente l’esserne venuti a conoscenza e presuppone la formazione ricevuta. La questione che si pone è piuttosto se la norma vada intesa nel senso che il preposto deve rilevare queste violazioni, o invece nel senso che il preposto deve agire solo se la deficienza sia stata rilevata. Nella prima ipotesi, in caso di deficienza accertata in sede ispettiva, il preposto risponde della violazione della lettera f-bis per il solo fatto che la deficienza c’è. Nella seconda ipotesi, non c’è violazione se il preposto non se ne è accorto; c’è invece violazione se il preposto non è intervenuto pur essendone consapevole; occorre cioè dimostrare che il preposto aveva rilevato la deficienza ma era rimasto inerte. E’ evidente, ai fini di una sanzione ma soprattutto in caso di infortunio, il diverso impatto che può avere, sulla responsabilità del preposto, l’una o l’altra interpretazione in presenza di una carenza tecnica che l’ispettore ex post ritenga rilevabile (ma che magari non lo era in maniera eclatante ex ante).
Un coordinamento migliore era probabilmente auspicabile anche rispetto all’obbligo della lettera e), che in caso di pericolo “grave ed immediato” imponeva al preposto di “astenersi” dal far “riprendere” l’attività, ma non attribuiva al preposto un esplicito potere/dovere di interruzione.
In ogni caso, ciò che rileva è che ora, in caso di deficienza tecnica rilevata, la lettera f-bis) pone in capo al preposto un dovere esplicito di valutare la necessità o meno di una interruzione anche solo temporanea, e non più di limitarsi a segnalare la carenza ai superiori.
L’interruzione dell’attività non è automatica, perchè occorre una valutazione del preposto sulla “necessità” della interruzione. Ma cosa significa “se necessario”?
E’ ragionevole ritenere che vada applicato anche qui il criterio del “pericolo grave ed immediato”, che attraversa tutto l’art. 19 e che in ogni caso costituisce principio ispiratore nella contrapposizione degli interessi in gioco. E’ peraltro evidente l’impatto che la decisione di interrompere o di proseguire l’attività possono avere sul preposto, in caso di incidente futuro causato da una condizione di pericolo da lui rilevata, ma non ritenuta sufficiente a giustificare una interruzione dell’attività.
L’interruzione in ogni caso non esaurisce gli obblighi del preposto, che ha comunque un dovere di segnalazione ai superiori: attività quest’ultima che in una prospettiva di sistema assume ancora una volta una rilevanza centrale, al fine di stabilire se la disfunzione sia qualificabile come “aziendale” e imputabile ai livelli apicali, o sia invece una disfunzione “operativa” da imputare ai livelli esecutivi.
Peraltro, poiché nella lettera f-bis) non si tratta di comportamenti dei lavoratori ma di circostanze oggettive, il coinvolgimento dei ruoli apicali appare in questa fattispecie, rispetto alla lettera a), più agevole da dimostrare perché si sta discutendo di aspetti strutturali o comunque legati alla dotazione o alla organizzazione aziendale; anzi, proprio la natura del presupposto pone l’esigenza di ampliare l’attenzione a tutti i soggetti del sistema di sicurezza aziendale che della deficienza tecnica o organizzativa avrebbero potuto/dovuto accorgersi, ivi compreso il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Naturalmente, per tale Servizio e per il RSPP diventa fondamentale la questione, se il Servizio sia stato portato a conoscenza della circostanza (o dal preposto direttamente, o dai superiori da quello informati); così come è fondamentale distinguere le fattispecie in cui la deficienza o la condizione di pericolo siano riconducibili a carenze della valutazione del rischio, da quelle fatte oggetto di adeguata valutazione del rischio (e magari addirittura di segnalazione specifica da parte del RSPP) ma non debitamente gestite dall’organizzazione.
3. La nuova governance aziendale. L’obbligo di individuazione del preposto o dei preposti
3.1 L’obbligo formale di individuazione
La riforma pone a carico del datore di lavoro un obbligo specifico ed esplicito di individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.
Per cogliere il significato di questo obbligo, non si può non considerare che datore di lavoro/dirigente/preposto costituiscono da sempre le posizioni di garanzia tipiche del sistema di sicurezza disegnato dal legislatore nazionale (cfr. anche l’art. 299 del Decreto 81/08) e che la definizione di preposto – inteso come soggetto contraddistinto da una posizione di sovraordinazione gerarchica e funzionale che soddisfa i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) del Decreto 81/08 e come tale è titolare di un potere/dovere di garanzia a titolo originario – è rimasta assolutamente identica con la riforma.
La nuova disciplina non mette dunque in discussione il fatto che il preposto è, all’interno dell’organizzazione, un soggetto che esercita un potere gerarchico e funzionale su altri lavoratori: né mette in discussione il principio secondo cui l’obbligo di vigilanza è la conseguenza di quei poteri, senza i quali non potrebbe esservi posizione di garanzia.
D’altro canto, la posizione di garanzia, come recita appunto l’art. 299 del Decreto 81/08 oltre che da sempre la giurisprudenza, prescinde da una “investitura formale” e manca a volte di una esplicitazione all’esterno.
E’ in questa prospettiva che va letto, a nostro avviso, il riferimento del legislatore ad una individuazione, da intendere come azione con la quale si mette in evidenza, si porta all’attenzione, si formalizza, ciò che è già presente ma potrebbe non essere esplicito: azione ben diversa dalla nomina, cioè dalla attribuzione ad un soggetto di una qualifica e di un ruolo che senza l’atto formale quel soggetto non avrebbe.
Non appare possibile, a nostro avviso, ritenere che la riforma abbia voluto individuare una figura del tutto nuova di preposto, inteso non come soggetto titolare di un ruolo sovraordinato agli altri lavoratori con poteri gerarchici e funzionali nell’esercizio dell’attività lavorativa, bensì come soggetto affidatario di una attività di vigilanza intesa come vera e propria mansione lavorativa da attribuire con un atto dedicato. Non si tratterebbe di un preposto, ma di un vigilante o controllore che dir si voglia: nozione evidentemente diversa, e che nei contenuti sia letterali che sistematici della riforma non è dato rinvenire.
La novità della riforma sta invece nel fatto che, introducendo l’obbligo di individuazione, si sancisce il principio per cui in ogni organizzazione la presenza del preposto dovrà d’ora in poi essere anche formalizzata e resa nota, attraverso un atto/provvedimento/documento formale da cui si evinca quali sono in azienda i preposti.
Il che significa – conseguenza non banale – che la mancanza di un tale atto/provvedimento/documento formale è sufficiente per applicare nei confronti del contravventore la sanzione amministrativa di euro 1.500,00 mediante prescrizione ai sensi del Decreto n. 758/1994 (un quarto del massimo dell’ammenda di euro 6.000,00 prevista dal nuovo art. 55, comma 5 lettera d).
*
“Individuare” il preposto, peraltro, non significa necessariamente redigere un atto con il quale un soggetto, individuante, comunica ad un altro soggetto, individuato, che quest’ultimo è un preposto; non significa neppure redigere una lista intitolata “Individuazione preposti”.
Certo questi possono essere alcuni dei modi per assolvere l’obbligo; ma non sono certo gli unici, né sarebbe condivisibile una interpretazione formalistica che pretendesse di trovare un documento di questo tipo, magari disinteressandosi della effettiva organizzazione aziendale e della effettiva esistenza di preposti individuati.
“Individuare” significa piuttosto porre in essere una azione, il cui risultato finale sia quello di esplicitare che un lavoratore è, in quella organizzazione, un preposto: significa accompagnare un nome ad una posizione.
Non si deve dunque ricercare un “atto di individuazione” inteso come atto individuale; può esserci ma non è essenziale; l’obbligo deve intendersi adempiuto, tutte le volte che nel sistema aziendale vi sono documenti o atti di qualsiasi natura aventi rilevanza esterna, dai quali si possa evincere con certezza che taluni soggetti ricoprono in azienda un ruolo di preposto.
Può trattarsi dell’organigramma, del funzionigramma, del mansionario, delle job descriptions; può trattarsi del Sistema di Gestione della Sicurezza o del Modello Organizzativo; può trattarsi perfino dell’elenco degli iscritti al corso di formazione specifica per preposti. Proprio l’adempimento dell’obbligo formativo in favore dei preposti, già esistente nell’ordinamento da anni, costituisce lo strumento attraverso il quale l’individuazione di essi è già stata compiuta da tutte le organizzazioni che quell’obbligo hanno assolto; sicchè la necessità di una individuazione si pone semmai nei confronti delle organizzazioni che i preposti ad oggi non li hanno ancora formati.
Ciò che conta è che l’informazione sia esplicitata.
Non è neppure necessario, che l’atto di individuazione o il documento aziendale affidino formalmente al preposto l’incarico di svolgere l’attività di vigilanza: l’obbligo di vigilanza continua a rimanere, per il preposto, un obbligo connaturato alla funzione, obbligo che deriva a titolo originario dal fatto di essere preposto e non dal conferimento di una delega apposita.
Il fatto che il legislatore parli di “individuazione” e non di “nomina” è un indice inequivoco in questo senso; e ciò implica un’altra considerazione assolutamente fondamentale, e cioè che la individuazione del preposto non richiede una accettazione del preposto individuato, né consente un rifiuto o una rinuncia.
L’individuazione dei preposti, in ultima analisi, non è altro che una fotografia dell’organizzazione così come essa è ed opera; ha una finalità dichiarativa ed informativa, non una finalità costitutiva.
Perché allora, si potrebbe obiettare, il legislatore ha prescritto uno specifico obbligo di individuazione del preposto, se in realtà questo non significa “creare” un preposto là dove non esisteva?
La risposta sta nel fatto che l’individuazione, ben lungi dall’essere fine a se stessa, è momento propedeutico e indispensabile per l’assolvimento degli obblighi ulteriori previsti dalla riforma, e alla fine per l’esistenza stessa di un sistema di vigilanza.
Senza l’individuazione, il datore di lavoro non può procedere alla formazione specifica del preposto né alla eventuale erogazione di un emolumento apposito; ma l’individuazione agevola anche l’esercizio delle azioni correttive perché concorre alla chiarezza dei ruoli nei reparti. Più in generale, attraverso l’opera di individuazione l’organizzazione è costretta a fare i conti con la propria stessa struttura, a valutarne l’adeguatezza o le carenze.
Nel momento in cui il legislatore ha inteso rafforzare la vigilanza, ed ha deciso che per farlo era necessario rafforzare il ruolo del preposto, ha fatto in modo che nelle organizzazioni questo ruolo uscisse dall’ombra e dall’incertezza.
3.2 L’individuazione del preposto “o dei preposti”.
La norma prevede l’obbligo di individuare il preposto o “i preposti”.
Non viene specificato il numero e neppure vengono posti limiti minimi o soglie massime; ciò è da condividere, perché quanti sono i preposti all’interno di una organizzazione dipende dalla dimensione, composizione e struttura di ogni organizzazione.
Non appare possibile, tanto considerato, che venga contestata la violazione dell’obbligo sotto il profilo – ad esempio – di un numero di preposti non adeguato alle dimensioni aziendali, o alla distribuzione delle funzioni; si tratterebbe di una inammissibile interferenza dell’organo ispettivo – e/o del Giudice – nell’autonomia organizzativa e imprenditoriale del datore di lavoro.
Ciò su cui l’organizzazione deve, piuttosto, porre l’attenzione è la adeguatezza del numero dei preposti rispetto alle finalità sostanziali perseguite dalla norma, che sono quelle di assicurare (come recita appunto la lettera b-bis) “l’effettuazione dell’attività di vigilanza”; e come si è visto, ora l’attività di vigilanza si concretizza nell’assolvimento degli obblighi e nell’esercizio delle azioni che il nuovo art. 19 scandisce in maniera molto puntuale e che comportano, anche dal punto di vista formale e della registrazione degli adempimenti (anche solo a fini di prova) rinnovata attenzione.
3.3 Le organizzazioni senza preposto: la vigilanza del datore di lavoro e i lavori in solitudine.
La previsione di un esplicito obbligo di individuazione “del preposto” rinnova, sotto nuova prospettiva, sia la tematica della vigilanza espletata dal datore di lavoro in assenza di preposti, sia la tematica del lavoratore in solitudine.
Ci si deve domandare infatti se la nuova lettera b-bis) dell’art. 18 possa essere intesa, nel senso di imporre al datore di lavoro di individuare comunque almeno un preposto, sempre ed in ogni organizzazione.
Ci sono moltissime organizzazioni di modesta dimensione, in cui la vigilanza è svolta direttamente dal datore di lavoro in quanto presente sul luogo di lavoro, e nelle quali pertanto un preposto non è presente. Esse rappresentano notoriamente la maggioranza o comunque una percentuale elevatissima delle organizzazioni esistenti sul territorio nazionale.
La norma a nostro avviso non può essere letta nel senso di imporre la necessaria presenza di almeno un preposto in ogni organizzazione.
Non ci sono elementi letterali per sostenere questa conclusione; soprattutto non ci sono elementi sostanziali, perché l’art. 18 interviene su un profilo di natura organizzativa volto a rendere formale ciò che è nella sostanza delle aziende, ma non interviene – né potrebbe – a modificare quella sostanza; del resto, la definizione di preposto di cui alla lettera f) dell’art. 2 del Decreto 81/08 rimane immutata, ed è una nozione basata su un principio di effettività che riconduce direttamente ed esclusivamente alla struttura produttiva delle organizzazioni.
In sostanza, la norma non può essere letta nel senso di imporre al datore di lavoro di attribuire ad almeno uno dei propri lavoratori un ruolo di sovraordinazione sugli altri; non può essere intesa nel senso di imporgli di creare un capo-reparto o un capo-squadra là dove non c’è e dove il datore di lavoro non ha mai ritenuto necessario che ci sia.
Si deve ritenere pertanto che il datore di lavoro possa continuare a svolgere “in proprio” la funzione di vigilanza, in attuazione dell’obbligo (non modificato) di cui all’art. 18; se un lavoratore sovraordinato agli altri non c’è, potrà continuare a non esserci.
Naturalmente, vale anche per queste micro-organizzazioni l’obbligo di individuazione formale del preposto, là dove questa figura esista nei fatti; inoltre, e soprattutto, è necessario per queste micro-organizzazioni (per il datore di lavoro) attuare l’obbligo di vigilanza con accresciuto rigore, conformemente alla stretta imposta dal legislatore alla disciplina.
Coerenza di sistema impone, infatti, di ritenere che il datore di lavoro che esercita in proprio la vigilanza sia chiamato ad assicurare un livello di controllo almeno pari a quello che il preposto è tenuto a svolgere ai sensi delle rinnovate lettere a) e f-bis) dell’art. 19; in sostanza, il datore di lavoro dovrà assicurare personalmente l’assolvimento di tutte le azioni di vigilanza, di intervento e di correzione ivi così dettagliatamente elencate.
Un ultimo e diverso profilo riguarda invece i lavoratori in solitudine, rispetto ai quali la tematica si ripropone tutto sommato con le medesime caratteristiche che già aveva prima della riforma, posto che le norme non possono imporre un determinato assetto organizzativo e non appare possibile leggere la riforma come l’introduzione di un divieto di lavoro in solitudine; anche in questo caso, nondimeno, il presupposto della “solitudine” da un lato ed i requisiti del lavoratore solitario dall’altro andranno analizzati con accresciuto rigore dal punto di vista organizzativo, coerentemente con l’accresciuto rigore che il legislatore ha imposto alla disciplina della vigilanza.
4. Il preposto come soggetto “qualificato”. Le condizioni per l’esercizio della funzione
In una riforma (quella degli articoli 18 e 19) finalizzata a garantire la “effettività della vigilanza”, il legislatore ha ritenuto necessario puntare sul preposto come snodo fondamentale del sistema: gli obblighi sono stati resi più espliciti (e quindi meno giustificabile la loro omissione) in termini di presupposto e di contenuto delle azioni da porre in essere; le azioni del preposto sono più impattanti per l’organizzazione, da un lato incidendo sull’operatività immediata, dall’altro sollecitando i livelli superiori in maniera più formalizzata e più incisiva; le responsabilità non sono più le stesse di prima.
Questo rinnovato ruolo del preposto ha reso necessario riconsiderare la figura all’interno del sistema aziendale, ed in questa prospettiva si collocano le ulteriori modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021, che incidono su quelli che possiamo definire come i requisiti caratterizzanti di una figura “qualificata” rispondente al nome di preposto.
Il primo di questi profili riguarda la formazione del preposto.
L’assolvimento dei rinnovati obblighi presuppone un adeguato patrimonio di competenze e di conoscenza sia delle regole di sicurezza in generale, sia dei processi aziendali, sia delle peculiarità che contraddistinguono figura, attività ed obblighi del preposto.
A questo scopo viene rafforzato un obbligo già esistente, e cioè l’obbligo di formazione del preposto: il comma 7-ter dell’art. 37 ribadisce i principi noti di adeguatezza e specificità della formazione, nonché l’obbligo dell’aggiornamento periodico, ma impone la modalità della formazione “interamente” in presenza e la cadenza almeno biennale e comunque in ogni circostanza di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi; al nuovo obbligo corrisponde una nuova specifica sanzione.
La ratio della norma è evidente: la vigilanza dell’art 19 presuppone la capacità del preposto di individuare le non conformità comportamentali così come le deficienze tecniche e le condizioni di pericolo, di dare al lavoratore informazione diretta delle giuste manovre, di valutare la necessità o meno di interruzione di una attività, di trasmettere ai superiori le segnalazioni necessarie.
Tutto questo può aversi soltanto con una adeguata formazione, che sarà formazione sulle macchine e attrezzature specificamente presenti ed utilizzate là dove opera quel preposto, sulle procedure lavorative ivi attuate; ma anche formazione sugli obblighi e sulle responsabilità; e ancora, formazione sui comportamenti e sugli insegnamenti da dare.
Il legislatore ha scelto di farlo tramite una formazione per il preposto “diversa” dalle altri formazioni, quanto a modalità e tempistiche. A prescindere da ogni criticità di merito (ad esempio, le modalità di calcolo del termine “biennale”), non si può non vedere in questa scelta quantomeno una perplessità del legislatore sulla reale efficacia della formazione così come fino ad oggi concepita. Considerata la portata dell’argomento, la sola cosa che si può fare in queste brevi note è rilevare come, ancora una volta, affrontare il tema della vigilanza, e cioè della sicurezza praticata in concreto, renda inevitabile una riflessione generale sul fondamentale tema della formazione.
Il secondo intervento legislativo di questo contesto è quello economico, e consiste nel prevedere la possibilità di riconoscere al preposto, tramite lo strumento della contrattazione collettiva, un emolumento per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’art. 19.
Il punto appare delicato, dal punto di vista della configurazione giuridica della posizione di garanzia.
Come si è visto, esigenze di effettività della vigilanza hanno indotto il legislatore ad imporre una formale individuazione dei preposti.
Ma, come pure si è visto, l’individuazione non consiste in una nomina, né nel conferimento di una delega e/o di un potere derivato, bensì nella formalizzazione di un ruolo che deriva al preposto in ragione della posizione di supremazia concretamente rivestita nell’organizzazione: “il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici” e risponde “a titolo diretto e personale” (cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 25836/2019).
Da tanto discende che il riconoscimento di un emolumento economico al preposto “per lo svolgimento dell’attività di vigilanza” può essere concepito soltanto come trattamento economico aggiuntivo (laddove la contrattazione collettiva lo prevederà) che consegue automaticamente alla circostanza oggettiva di copertura del ruolo di preposto; in sostanza, la nuova lettera b-bis dell’art. 18 è un invito alle parti sociali a valorizzare economicamente il ruolo e la funzione del preposto come categoria di lavoratore, e non la previsione di un compenso da riconoscere come soggetto individuale.
Ciò che si vuol dire è che l’effettuazione dell’attività di vigilanza non può essere considerata, per il solo fatto che è ora suscettibile di un emolumento economico dedicato, come una mansione aggiuntiva che il lavoratore può accettare o rifiutare, accettando quindi o rifiutando la corrispondente quota di retribuzione.
Come è da sempre nel sistema normativo nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, la funzione di preposto non è oggetto di negoziazione e l’attività di vigilanza non è oggetto di accettazione: il preposto è tale quando riveste un ruolo aziendale che lo rende un soggetto sovraordinato ad altri (ed ora la riforma impone di individuarlo espressamente), e come preposto ha l’obbligo normativo ed originario di eseguire la vigilanza (ed ora la riforma consente alle parti sociali di riconoscergli un emolumento).
Ciò che ora accade è che il fatto di essere destinatario di un obbligo normativo dà diritto al preposto (se le parti sociali lo decideranno) di avere una somma di denaro, che diventa una sorta di “premio” per il fatto di avere quell’obbligo.
Il legislatore ha stretto le maglie nei confronti del preposto; ma trattandosi di un lavoratore e non di un soggetto apicale, ha evidentemente ritenuto opportuno accompagnare questa stretta con una contropartita economica.
Si tratta, in sostanza, di una posizione di garanzia che diventa in qualche misura “a pagamento”; ma proprio perché non è un vero e proprio corrispettivo, la decisione non solo sul quanto, ma anche sul se erogare l’emolumento è stata rimessa alle parti sociali.
Ovviamente, non sarà possibile per il datore di lavoro assoggettato al contratto collettivo non corrispondere l’emolumento a tutti i propri preposti; per contro il preposto che non si vedesse riconosciuto l’emolumento sancito dalla contrattazione collettiva, avrà naturalmente diritto di agire per ottenerne in via coattiva il pagamento. Appare da escludere, però, la possibilità per il preposto di omettere la vigilanza in caso di mancata erogazione: questo perché l’obbligo, come detto, è e rimane obbligo normativo a titolo originario.
Infine, la nuova condizione che la riforma riconosce al preposto è un diritto di protezione contro i pregiudizi che potrebbe subire a causa dello svolgimento della propria attività.
E’ una norma che testualmente riecheggia l’art. 31 comma 2 del Decreto 81/08 a tutela del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e che appare volta a prevenire l’adozione, da parte del datore di lavoro e del dirigente (ma in generale da parte dell’intera organizzazione, compresi i lavoratori vigilati) di condotte volte a dissuadere il preposto dal compimento dei suoi obblighi, o a punirlo per averli adempiuti. Va osservato peraltro che il legislatore non ha usato in questa sede le formule di tutela particolarmente rigorose utilizzate, ad esempio, nella disciplina di protezione del whistleblower di cui all’art. 6 del Decreto 231/2001.
Di certo il legislatore mostra di voler fare del preposto, in maniera definitiva e inequivoca, uno strumento di controllo dell’organizzazione dall’interno, e di lotta alle prassi aziendali scorrette; è una posizione di antitesi rispetto a quella del datore di lavoro, o del dirigente, o financo dei lavoratori che volessero praticare prassi scorrette per comodità o per altri fini.
Il legislatore ci dice che la vigilanza è una parte fondamentale del sistema, e ci dice che il preposto è il cardine dell’azione di vigilanza; per questo motivo l’organizzazione deve fare quanto necessario – e quanto ora espressamente imposto dalla norma – per metterlo in condizione di lavorare al suo meglio.
5. Esiste ancora il preposto “di fatto”?
Una considerazione finale riguarda le conseguenze profonde della riforma.
Il preposto è sempre stato considerato, dalla tradizionale lettura giurisprudenziale, una figura “anche di fatto”: il preposto è tale in ragione dei poteri che esercita, indipendentemente da una investitura formale, e in questo senso è stato scritto l’art. 299 del Decreto 81/08 che ha recepito decenni di sentenze in questo senso.
Si può anzi dire che il preposto è la figura paradigmatica del principio di effettività, incarnando nella maniera più esemplare la veste della posizione di garanzia che è tale per i poteri che esercita, indipendentemente da una investitura formale.
Si diventa preposti nel momento in cui si viene assegnati al ruolo di caposquadra, capocantiere, responsabile di reparto, e così via: oppure perfino quando, senza assumere formalmente alcun ruolo sovraordinato, la sovraordinazione viene comunque esercitata nei fatti.
Questa natura “fattuale” in realtà ha cominciato ad affievolirsi con l’introduzione dell’obbligo di formazione del preposto di cui all’art. 37 del Decreto 81: formare un preposto presuppone di averlo riconosciuto come tale, e pertanto l’individuazione del preposto è divenuta (per quanto indirettamente) una necessità, nel momento in cui si è dovuto effettuarne la formazione.
Però la situazione era sempre rimasta per così dire a metà del guado; tanto che non sono mancate le sentenza di condanna del preposto di fatto pur non sottoposto alla dovuta formazione, già solo per avere intrapreso l’attività pur non avendo le conoscenze necessarie (cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 18090/2017).
Ora la riforma della figura del preposto spinge ulteriormente nel senso della sua qualificazione e della sua manifestazione formale; il che rende inevitabile domandarsi, se possa ancora esistere il preposto come posizione di garanzia “di fatto”.
Se il datore di lavoro ha un obbligo esplicito di individuare i preposti, può essere considerato preposto (e quindi destinatario dei relativi obblighi) un soggetto che non è stato individuato come tale?
Se il preposto deve ricevere una adeguata formazione, addirittura speciale rispetto alle altre, può qualificarsi preposto un soggetto che non ne è stato destinatario (e che non ha dunque i requisiti che la norma ritiene necessari per svolgere la funzione)?
A noi pare che, se il preposto viene individuato come tale, ma poi il datore di lavoro non assolve agli obblighi conseguenti, non si tratti di un preposto di fatto: si tratta di un preposto individuato, rispetto al quale si pone la questione di come valutare gli obblighi previsti ex lege, a fronte delle omissioni datoriali. E questo sarà, dopo questa riforma, un tema tutto da esplorare.
Ma il preposto neppure individuato? Dobbiamo escludere che sia un preposto? Dobbiamo pensare che il legislatore abbia disegnato un nuovo sistema di sicurezza aziendale, in cui in assenza di individuazione, chi ha posizioni sovraordinate sugli altri lavoratori sarebbe ciononostante esonerato da obblighi di garanzia?
Come sopra si è già ricordato, questa conclusione non appare consentita alla luce della riforma, che non ha modificato la definizione di preposto e la sua natura di soggetto garante in quanto titolare di poteri gerarchici; la stessa individuazione non costituisce un conferimento di poteri e di mansioni, ma il riconoscimento di una realtà esistente. D’altro canto, se il preposto non viene individuato come tale dal datore di lavoro, non per questo viene meno la sua posizione sovraordinata sugli altri lavoratori, che comunque continueranno a riconoscerlo come tale.
Tuttavia, è indubbio che in un sistema dove i preposti devono essere individuati, l’omessa individuazione (l’omessa “investitura formale”) rischia di mettere in crisi la logica dell’effettività.
6. Politica aziendale e responsabilità 231 dell’ente
E’ certo che, con questa riforma della vigilanza, l’attenzione del datore di lavoro e dell’intera organizzazione agli aspetti di governance deve aumentare ulteriormente.
Nella nuova prospettiva data dal legislatore, l’obbligo di individuazione dei preposti appare come un momento fondamentale (sia nella forma, sia nella sostanza) nella configurazione dell’assetto di sicurezza di una organizzazione.
Certo, sul piano organizzativo gli obblighi di formazione e di tutela da ritorsioni del preposto sono centrali perché funzionali ad un efficace espletamento dei suoi obblighi, e l’emolumento economico è un incentivo e un riconoscimento all’importanza del ruolo; ma in termini strategici, è l’obbligo di individuazione che si configura come il vero perno della “nuova” vigilanza disegnata dal legislatore attorno alla figura del preposto.
La mancata individuazione dei preposti, e la carenza di vigilanza che ne deriva, costituiscono espressione di una inadeguatezza dell’assetto organizzativo; e questa è ovviamente imputabile totalmente ed esclusivamente ai soggetti apicali, datore di lavoro e dirigenti.
Per converso, l’adempimento degli obblighi di individuazione/formazione, accompagnato dalle misure economiche e dalla assenza di comportamenti ritorsivi, costituiscono gli elementi di un sistema aziendale virtuoso in cui la funzione di vigilanza è assicurata in maniera efficace attraverso l’operato del preposto in quanto “qualificato” soggetto di garanzia.
Letta in questi termini, la riforma degli articoli 18 e 19 si mostra come un intervento che punta al perseguimento di assetti organizzativi adeguati in ogni realtà lavorativa, secondo una logica molto vicina a quella di un sistema di gestione.
Alla fine, l’attenzione data (o non data) alla figura dei preposti è destinata a diventare un segno importante della “politica aziendale”, con valenza quindi non soltanto per le persone fisiche che rivestono posizioni di garanzia, ma anche per l’ente e per la sua responsabilità ai sensi del Decreto 231.