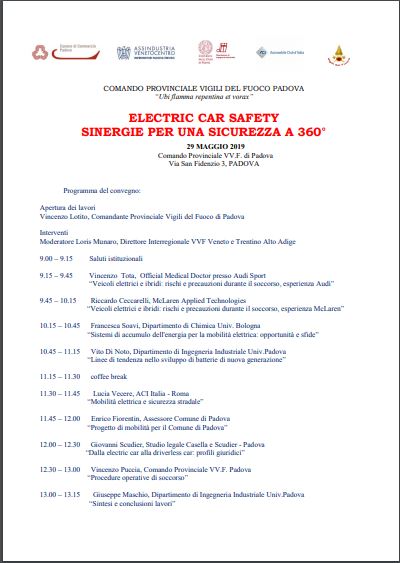Smart Working per Coronavirus: lavoro agile, ma con molte differenze
Il DPCM 11 marzo 2020 conferma all’art. 1, comma primo, numeri da 6 a 10, il ricorso alla “modalità di lavoro agile” come misura di contenimento del contagio; non viene però soppresso l’art. 2 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, le cui misure vengono private di efficacia soltanto “ove incompatibili”.
Di fatto, lo Smart Working si stava già rivelando lo strumento maggiormente utilizzato dai datori di lavoro per fare fronte all’emergenza Coronavirus: a tale diffuso impiego sicuramente concorrevano le agevolazioni date fin dai DPCM di febbraio rispetto alla modalità tipica di lavoro agile prevista dalla Legge n. 81/17.
Le semplificazioni previste erano due e sono note: la prima consiste nella applicabilità dello strumento “anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”; la seconda consiste nella possibilità di assolvere gli “obblighi di informativa” sui rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità lavorativa “in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL”.
Vi era poi un terzo punto che contraddistingue la fattispecie, e cioè il fatto che è prevista per tali condizioni semplificate una finestra temporale ben precisa, vale a dire “per la durata dello stato di emergenza” e quindi per sei mesi dal 31 gennaio 2020 (durata sancita dalla Delibera del Consiglio dei Ministri di pari data).
Il DPCM 11 marzo 2020 modifica in parte il quadro; vediamo in quali punti, e vediamo se ne altera i presupposti di fondo.
Innanzitutto, la nuova disposizione detta discipline diverse per le pubbliche amministrazioni (art. 1 n. 6) e per le attività produttive e professionali (art. 1 n. 7-10).
Alle pubbliche amministrazioni si prescrive:
- che venga assicurato “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile”;
- questo “anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi”;
- inoltre, le p.a. “individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.
Per le attività produttive e professionali, invece, non vi sono prescrizioni, perché la norma “raccomanda”; il che lascia aperti al datore di lavoro gli spazi di esercizio della propria autonomia imprenditoriale, purtuttavia da contemperare con le indicazioni del Governo che sono, con l’ultimo DPCM, alquanto stringenti.
Tali indicazioni sono nel senso di:
- fare “il massimo utilizzo” del lavoro agile per le attività che “possono” essere svolte a domicilio o con modalità a distanza, e comunque per tutte le attività non sospese;
- incentivare ferie e congedi;
- sospendere le attività dei reparti non indispensabili;
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, con la distanza interpersonale di un metro come misura principale e, ma solo come scelta subordinata, con la adozione di d.p.i.;
- incentivare operazioni di sanificazione;
- limitare al massimo spostamenti all’interno dei siti e contingentare gli accessi agli spazi comuni (per le attività produttive).
Specificamente per le attività produttive, “si favoriscono intese” tra le organizzazioni datoriali e sindacali.
Largo allo Smart Working, dunque?
Sì, ma con alcune precisazioni, dai numerosi effetti pratici.
La prima cosa da sottolineare, la più importante, è che non si tratta di applicazione dello Smart Working tradizionalmente inteso, così come disciplinato dalla Legge n. 81/17: si tratta di una fattispecie del tutto peculiare, che potremo chiamare “Smart Working per Coronavirus”, la quale ha una disciplina giuridica sua propria con condizioni sue proprie e adempimenti suoi propri.
Questa disciplina risulta attualmente costituita dalla combinazione di due disposizioni: una è l’art. 1 nn. 6-10 del DPCM 11 marzo 2020; l’altra è l’art. 2 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, che rimane a nostro avviso efficace in quanto compatibile con la più recente disposizione.
La seconda cosa da sottolineare è che, all’interno di questa nuova fattispecie di lavoro agile, l’ultimo DPCM ha creato due percorsi diversi e distinti tra pubbliche amministrazioni ed attività private; di queste differenze occorre dare conto nel seguito della trattazione.
La terza cosa da sottolineare, di rilievo squisitamente pratico, è che, per porre in modalità agile i lavoratori secondo il DPCM 11 marzo 2020, non è possibile utilizzare tout court i testi e i modelli che nel tempo erano stati predisposti per lo Smart Working “normale”; è vero che le semplificazioni introdotte dai DPCM rendono il ricorso all’istituto più accessibile, ma è anche vero che lo fanno “trasformandolo” in qualcosa di diverso, e quindi occorre modulare lo strumento alle specifiche condizioni che gli sono proprie.
Vediamo dunque quali differenze, anche nella gestione formale, contraddistinguono lo “Smart Working per Coronavirus”.
- Lavoro agile, o “lavoro a casa”? Smart Working, o Home Working?
Il primo tema da affrontare riguarda il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa agile “per Coronavirus”.
Come noto, secondo la legge n. 81/17 “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno” e l’accordo individuale disciplina proprio “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali”, la quale si contraddistingue per essere svolta “senza precisi vincoli di luogo di lavoro” e “senza una postazione fissa”: non si tratta dunque né di lavoro a domicilio, né di telelavoro o lavoro a distanza, ma di prestazione in un luogo che viene “scelto” dal lavoratore a seconda delle sue esigenze personali.
I DPCM sul Coronavirus non facevano cenno al luogo; il DPCM 11 marzo 2020 lo fa indirettamente, raccomandando l’utilizzo della modalità agile “per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
La domanda è: il lavoratore agile “per Coronavirus” è libero di svolgere la propria prestazione dove vuole, o esistono dei vincoli? E come deve essere gestito questo aspetto nel provvedimento del datore di lavoro che dispone la modalità agile?
A nostro avviso, per trovare la risposta si deve partire da un dato di fatto indiscutibile, e cioè che il lavoro agile è stato agevolato dal Governo in funzione di un presupposto ben preciso, e cioè la esistenza di un rischio di contagio, e con una finalità ben precisa, e cioè la introduzione di misure volte a favorire il contenimento del contagio.
Non si tratta soltanto di evidenza intuitiva, ma anche di precisi dati normativi in questo senso.
Mentre il primo D.L. n. 6/2020 – che dà la cornice legislativa primaria ai successivi DPCM – non menzionava il lavoro agile, il D.L. n.9/2020 sancisce lo scopo di agevolare il lavoro agile “quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica”.
Anche il DPCM 11 marzo 2020 include il lavoro agile tra le misure adottate “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.
Inoltre, se si guarda al crescendo dei successivi DPCM, l’accesso al lavoro agile “semplificato” è stato previsto dapprima (DPCM 23 febbraio) “nell’ambito di aree considerate a rischio”; poi (DPCM 25 febbraio 2020) per i “datori di lavoro aventi sede legale o operativa” in Veneto e altre Regioni interessate nonché “per i lavoratori ivi residenti o domiciliati” che lavoravano “fuori da tali territori”; infine (DPCM 1 marzo 2020) è stato esteso “sull’intero territorio nazionale”.
Non solo la dimensione territoriale, ma anche la durata della applicabilità delle misure di semplificazione ha seguito l’estendersi del rischio di contagio e della necessità di contenimento; dapprima previsto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, l’istituto è stato esteso infine all’intera durata dello stato di emergenza.
Non vi sono dubbi dunque sul fatto che per il Governo lo Smart Working è una misura di prevenzione, nella misura in cui consente di limitare la presenza di persone nei luoghi di lavoro; non vi sono dubbi che è stato semplificato per questo motivo.
Ma si tratta del lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017, o di una forma tutta peculiare di lavoro agile che alla fine configura una fattispecie di “lavoro a casa”?
Con i primi DPCM di febbraio, il silenzio sul luogo di prestazione poteva forse essere inteso come volontà “soltanto” di evitare la presenza nei luoghi di lavoro di tutto il personale che poteva stare altrove (in altre parole: meglio le persone in giro, piuttosto che le persone assieme in azienda); ma oggi una tale lettura non è più possibile: il motto “IO RESTO A CASA” vale per il cittadino, ma vale anche per lo Smart Worker. Del resto, uno Smart Worker non potrebbe giustificare uno spostamento personale con le “comprovate esigenze lavorative”, perché non vi è un luogo nel quale egli “deve” recarsi.
Appare dunque ragionevole ritenere che lo “Smart Working per Coronavirus” è in realtà un “Home Working”.
Non di “lavoro agile” si tratta; bensì di “lavoro a casa”.
Non pare davvero possibile arrivare a conclusioni diverse leggendo l’art. 1 n. 7) lettera a) del DPCM 11 marzo 2020, che parla di lavoro “al proprio domicilio o in modalità a distanza”; non pare infatti ragionevole pensare, che il Governo abbia da un lato adottato misure che limitano fortemente la libertà di movimento delle persone al fine di farle rimanere a casa, e poi abbia aperto le porte ad un lavoro agile svolto ovunque. Appare più logico ritenere (salvo voler pensare ad una semplice imperfezione di scrittura) che si sia voluto consentire di individuare come luogo di svolgimento del lavoro agile non “il proprio domicilio”, bensì un altro luogo individuato dal lavoratore; ma sempre di luogo unico e fisso deve a nostro avviso trattarsi, e comunque sicuramente non può essere il “non luogo” che contraddistingue tipicamente il lavoro agile.
Come impatta questa conclusione sul contenuto dei provvedimenti, con i quali il datore di lavoro dà attuazione alla misura?
Il datore di lavoro potrebbe lapidariamente sancire nel provvedimento, con il quale assegna al lavoratore la modalità “agile”, che la prestazione deve essere svolta esclusivamente presso l’abitazione.
Questo probabilmente supporterebbe anche l’esercizio, da parte del datore di lavoro, dei propri poteri, quello direttivo, ma anche ed ancor più quelli di controllo e disciplinare: giacchè questi aspetti, tipicamente oggetto nella Legge n. 81/17 dell’accordo tra le parti, sono stati tutti tendenzialmente rimossi in questa fase emergenziale di riorganizzazione del lavoro, in cui l’accordo non c’è; ma certo non vanno dimenticati in una prospettiva generale.
In alternativa, il datore di lavoro potrebbe anche disporre il lavoro agile senza specificare nulla circa il luogo: interviene in questo caso, a definire il perimetro degli spostamenti del lavoratore, il contenuto integrativo dei DPCM con le misure di contenimento.
Quale che sia la soluzione prescelta, quello che appare superato sono – perché tecnicamente inapplicabili – i modelli-tipo di regolamentazione del lavoro agile in uso in questi anni, i quali alla voce “luogo di svolgimento della prestazione” fanno riferimento indistinto a “qualsiasi luogo” “altro luogo diverso dalla abitazione”, o simili espressioni.
Questa conclusione consente tra l’altro di chiarire alcuni equivoci sorti in passato, e che in qualche misura si sentono riproposti in queste ore, circa il contenuto degli obblighi delle parti del rapporto ai fini della sicurezza del lavoratore.
Per il lavoratore agile “normale” la prestazione fuori dell’azienda si svolge in un non-luogo: il luogo della prestazione, quando il lavoratore agile non è in azienda, viene individuato soltanto in negativo, per quello che non è (non è all’interno, non è in un posto fisso).
E’ nell’essenza stessa del lavoro agile, come prefigurato dalla Legge n. 81/17, che il luogo in cui svolgere la propria attività (il luogo di lavoro) venga scelto dal lavoratore, e che possa essere scelto di volta in volta, anche giorno per giorno, anche in luoghi diversi nello stesso giorno .
Ciò non soltanto esclude che vi sia la “disponibilità giuridica” del luogo di lavoro in capo al datore di lavoro, ma fa venir meno perfino la nozione stessa di “luogo” di lavoro: luogo di lavoro è ovunque il lavoratore voglia che lo sia.
Ma se è così, è da escludere che facciano capo al datore di lavoro, e che vadano fatti oggetto di valutazione dei rischi e di informativa, i rischi e le misure di prevenzione legati a specifici luoghi, abitazione del lavoratore compresa, alle condizioni degli impianti, alla adeguatezza dei locali, alle condizioni igienico-sanitarie, e così via.
Attribuire al datore di lavoro l’obbligo di accertare preventivamente la rispondenza del luogo in cui il lavoratore agile si muove, costituisce con tutta evidenza una contraddizione in termini.
Ebbene, se questo obbligo il datore di lavoro non ce l’ha per un lavoratore agile “normale”, per il fatto che non sa dove il lavoratore lavorerà, ebbene non ce l’ha neppure per lo “Smart Worker da Coronavirus” che lavora a casa: e l’obbligo non ce l’ha non solo perché si tratta di luogo del quale egli non può disporre, ma anche per l’ulteriore motivo, che non si tratta di un luogo di lavoro che il datore di lavoro può in qualche misura “scegliere”, “valutare”, dando o meno il suo consenso a che la prestazione si svolga proprio lì: il luogo di lavoro “abitazione” è, per lo “Smart Worker per Coronavirus”, un luogo di lavoro necessario.
Di nuovo risalta in tutta la sua rilevanza la natura emergenziale dello strumento: con quanto ne deriva, come tra poco si dirà, anche in relazione all’obbligo di informativa.
- L’assenza degli accordi individuali.
L’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore agile, secondo l’art. 2 della Legge n. 81/17, ha una valenza contrattuale (si tratta di una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, e come tale richiede la volontà di entrambi i contraenti), una valenza formale (la forma scritta serve ai fini “della regolarità amministrativa e della prova”), infine una valenza sostanziale rispetto alla parte caratteristica del rapporto, visto che disciplina “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali”.
In questo senso, l’accordo regola non solo gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecniche ed organizzative necessarie per la disconnessione, ma anche le forme del potere direttivo del datore di lavoro.
La deroga al principio dell’accordo individuale costituisce indubbiamente la misura più dirompente e più importante dello “Smart Working per Coronavirus”. Essa si spiega sia con l’esigenza di rapidità nella adozione della misura, sia con la circostanza che avendo finalità di prevenzione essa è una misura a favore del lavoratore; né la compressione dei diritti appare irragionevole considerato che si tratta di una semplificazione limitata nel tempo e con un termine ultimo ben preciso.
Sancita nel DPCM 8 marzo 2020 come in quelli precedenti, la locuzione “anche in assenza di accordi individuali” non si trova riproposta nel DPCM 11 marzo 2020 per le attività produttive e professionali; per le pubbliche amministrazioni invece il tema è riproposto, ma la formulazione è leggermente diversa: “anche in deroga agli accordi individuali”.
Questo non modifica, a nostro avviso, la regola di fondo che esclude la necessità di accordo individuale.
Una prima ragione è ancora una volta sistematica: sarebbe paradossale, se non addirittura schizofrenico, pensare che proprio il DPCM che più di tutti spinge sul lavoro agile come misura di prevenzione tornasse ad introdurre quell’elemento – l’accordo individuale – che fin da principio tutti i DPCM avevano escluso per esigenze di rapidità e di tutela.
Una seconda ragione è letterale, e deriva dal fatto che il DPCM 11 marzo 2020 non contiene, almeno per le attività produttive e professionali, la disciplina del lavoro agile per Coronavirus, occupandosi piuttosto di definire in quali circostanze al datore di lavoro è raccomandato di farne uso: le regole contrattuali (assenza di accordi individuali, obbligo di informativa) rimangono dunque quelle del DPCM 8 marzo 2020, che sicuramente sono compatibili ed anzi sono un riferimento obbligato.
Diverso è il discorso per le pubbliche amministrazioni, giacchè l’art. 1 n. 6) interviene sulla disciplina: ma a differenza dell’obbligo di informativa, per il quale c’è una novità sostanziale e cioè la deroga all’obbligo, per l’accordo individuale viene ribadito che le p.a. operano “anche in deroga”: il che può essere letto o nel senso che si deroga al principio, e quindi l’assenza di accordo è confermata anche se scritta in altro modo, oppure può essere letto nel senso di consentire la deroga agli accordi individuali che fossero già stati sottoscritti prima dell’emergenza.
Alla fine, non appare possibile avere dubbi sul fatto che l’accordo individuale non è richiesto.
Cosa significa questo per il datore di lavoro? Come va gestita questa circostanza, allorchè si decide di adottare la modalità agile per i lavoratori?
a)
In primo luogo, questo significa che la decisione di assegnare il lavoratore a modalità di lavoro agile (in realtà: a modalità di lavoro da casa) può essere assunta in via unilaterale dal datore di lavoro e non necessita del consenso del lavoratore.
Naturalmente sono fatti salvi i principi che stanno alla base dell’istituto; non sono dunque in discussione ad esempio né i trattamenti economico e normativo, né il diritto alla disconnessione.
Anche in questo caso, si tratta di una deroga che impatta fortemente sui tradizionali modelli-tipo.
Se vengono utilizzati i testi predisposti secondo la Legge n. 81/17, si troveranno espressioni come “accordo”, “concordato tra le parti”, e così via; il che è tecnicamente sbagliato, ma rischia anche di avere conseguenze pratiche inattese.
Ed infatti, se un provvedimento con queste espressioni venisse ora sottoposto alla firma del lavoratore e da questi sottoscritto, ben si potrebbe affermare che siamo di fronte ad un “accordo individuale tra le parti”: circostanza che il DPCM non vieta, nel senso che consente il lavoro agile “anche in assenza degli accordi”, ma certo non li esclude a priori.
In questo caso, potrebbe essere più complicato per il datore di lavoro pretendere di esercitare il potere unilaterale di gestione del lavoro agile, che il DPCM gli attribuisce; sicchè ad esempio potrebbero porsi dei problemi al momento in cui il datore di lavoro decidesse di esercitare il potere – che il DPCM gli dà – di modificare le condizioni del lavoro agile, se la modalità non derivasse da una assegnazione con provvedimento unilaterale, ma da un “accordo”.
b)
Un secondo aspetto di questo potere del datore di lavoro è il seguente: il datore di lavoro ha dei vincoli nell’esercizio del suo potere di decidere la modalità agile, o invece è libero di esercitarla nel pieno della sua autonomia di imprenditore?
Per le pubbliche amministrazioni il DPCM 11 marzo 2020 introduce una indicazione ben precisa: lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile deve essere assicurato “in via ordinaria”, e vanno individuate “le attività indifferibili da rendere in presenza”.
Se ne deduce, che il lavoro “in presenza” costituisce eccezione, e tale eccezione richiede una preventiva qualificazione di “indifferibilità” alle attività che vengono escluse dallo Smart Working.
La limitazione al potere decisionale del datore di lavoro è evidente.
Per le attività produttive e professionali, invece, il DPCM 11 marzo 2020 contiene una “raccomandazione” e non detta prescrizioni vincolanti; in pari tempo, il quadro delineato nel DPCM è chiaro nel senso di considerare lo Smart Working non solo come misura prevenzionale, ma anche come misura preferibile ad ogni altra.
Il “massimo utilizzo” è raccomandato per tutte le attività “che possono essere svolte” in modalità agile.
Non viene utilizzato qui il criterio della “indifferibilità”: il discrimine dipende dal fatto, se la modalità agile è “possibile” o meno.
Questo introduce il tema della fattibilità tecnica della misura: ambito nel quale sicuramente è da escludere l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di adottare seduta stante strumenti tecnologici o soluzioni lavorative smart, e che va piuttosto declinato come una raccomandazione a valutare se ci siano le condizioni per tecnologiche ed organizzative per lavorare da casa , ed attuare la modalità agile in massima misura dove queste condizioni esistono.
Nell’ambito di queste indicazioni, rimane in capo al datore di lavoro la decisione se ricorrere al lavoro agile. Non è dunque possibile per il lavoratore pretendere dal datore di lavoro l’applicazione della misura; parimenti ed a contrario, il lavoratore non potrà opporre un diniego al datore di lavoro che decide di applicarla.
Rimane in capo al datore di lavoro anche la decisione su chi assegnare al lavoro a casa e chi invece no.
Ancora, rimane in capo al datore di lavoro la decisione su quanta parte dell’orario di lavoro del lavoratore assegnargli a casa, e quanta tenere in azienda: con la ulteriore annotazione che nella Legge n. 81/17 il lavoro agile deve prevedere comunque almeno una parte di lavoro “all’interno dei locali aziendali”, mentre la natura eccezionale dell’istituto come previsto dai DPCM sembra tale da consentire invece (anche se non obbliga) una prestazione integralmente eseguita da casa.
Naturalmente, è una decisione che il datore di lavoro dovrà prendersi combinando le raccomandazioni sul lavoro agile con le altre che il DPCM 11 marzo 2020 introduce, fermo restando che le attività “in presenza” dovranno essere gestite secondo criteri di tutela dei lavoratori, nella prospettiva di specifici “protocolli anti-contagio” espressamente richiamati dal DPCM medesimo.
- La durata dello “Smart Working per Coronavirus”.
La Legge n. 81/17 regola la durata del lavoro agile demandandone la disciplina all’accordo individuale, che può scegliere tra applicazione a termine o a tempo indeterminato con diritto di recesso per entrambe le parti.
In mancanza di accordi individuali, come si deve regolare il datore di lavoro quanto alla durata della prestazione in modalità agile?
Secondo il DPCM 8 marzo 2020, che come detto rimane a nostro avviso la norma di riferimento per la disciplina contrattuale di questa specifica forma di lavoro agile, il lavoro agile può essere applicato, con le particolari condizioni semplificate, “per la durata dello stato di emergenza”: quindi, si tratta di strumento applicabile fino alla fine del mese di luglio 2020.
Ne consegue che qualsiasi rapporto che venga assegnato oggi in modalità agile “semplificata” comunque non potrà protrarsi oltre quella data: invero, le circostanze emergenziali appaiono come il presupposto normativo che integra condizione di liceità del rapporto contrattuale.
Alla fine dello stato di emergenza, dunque, il rapporto di lavoro agile – ove fosse all’epoca ancora svolto in modalità Smart – tornerà ad essere sottoposto alle regole generali del singolo contratto individuale di ciascun lavoratore.
Questa conclusione deve ritenersi applicabile sia se il datore di lavoro specifica, nell’atto di assegnazione, che l’assegnazione avrà termine con lo scadere dei sei mesi; sia se il datore di lavoro non specifica nulla, posto che si tratta appunto di condizione normativa.
Semmai, il datore di lavoro potrà valutare di non indicare una data fissa (31 luglio 2020) né un periodo fisso, limitandosi piuttosto a condizionare la durata dello Smart Working alla “durata dello stato di emergenza”: questo da un lato ne comporterebbe la cessazione nella ipotesi – da tutti auspicata – di una dichiarazione anticipata di revoca dello stato di emergenza, mentre dall’altro lato ne comporterebbe un automatico prolungamento in caso di allungamento dello stato di emergenza.
All’interno del periodo generale di ammissibilità dello strumento, si deve ritenere che al datore di lavoro sia attribuito anche il potere di prolungare un rapporto Smart previsto inizialmente per un periodo più breve, o di anticipare la cessazione di un rapporto Smart prima della data indicata nell’atto di assegnazione.
In questo senso depone, infatti, la scelta del Governo di attribuire al datore di lavoro il potere di decidere l’applicazione dello strumento in assenza di accordo.
Un limite temporale specifico esiste invece per le peculiari disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, che (art. 3) producono effetto dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.
Poiché si tratta di disposizioni che tengono fermo lo strumento in generale, salvo dettarne alcuni limiti transitori, se ne deduce che dopo il 25 marzo 2020 verrà meno l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di disporre la modalità agile di tutte le attività differibili, e verrà meno anche la deroga all’obbligo di informativa; per le attività produttive e professionali, dopo il 25 marzo 2020 verranno meno le raccomandazioni al “maggiore utilizzo possibile” e quindi l’autonomia del datore di lavoro tornerà ad ampliarsi.
- L’obbligo di informativa sui rischi: il documento INAIL
Tra i principi della Legge n. 81/17, vi è quello secondo cui (art. 18 co. 2) “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa” e (art. 22 co. 1) “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile”.
Come noto, la stessa Legge introduce uno strumento finalizzato a tali obiettivi, prevedendo (art. 22 co. 1) che il datore di lavoro “consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
Secondo i principi generali del Decreto 81/08, si deve ritenere che (in condizioni normali) questo adempimento presupponga le attività che gli sono prodromiche: valutazione nel DVR della scelta di ricorrere al lavoro agile (l’art. 29 del Decreto 81 richiede la rielaborazione del DVR “in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”; l’art. 28 prescrive di valutare i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”); informazione e formazione; adeguamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria; e così via.
Ebbene, il DPCM 8 marzo 2020 (come gli altri prima) mostrava di ritenere impossibili tali incombenti in situazione di emergenza, e faceva di conseguenza una scelta ben precisa: veniva menzionato solo l’obbligo di informativa, che restava confermato, ma ne veniva semplificato l’adempimento, non solo ammettendone l’esecuzione “in via telematica”, ma anche e soprattutto rimandando alla documentazione disponibile sul sito INAIL.
Per le attività produttive e professionali, questa disciplina è confermata, perché il DPCM 11 marzo 2020 nulla dice al riguardo.
La grande differenza è per le pubbliche amministrazioni, per le quali la modalità agile va adottata, almeno fino al 25 marzo 2020, “anche in deroga agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23” della Legge n.81/17.
Ora, il ricorso al documento INAIL è una deroga alla regola generale, se per rischi generali ai sensi dell’art. 22 intendiamo i rischi tipici generalmente connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile (rischi propri e caratteristici, in generale, di tutti i lavoratori agili) mentre per rischi specifici intendiamo i rischi cui ogni specifico lavoratore agile è esposto in relazione all’attività svolta ed alle specifiche modalità concordate di volta in volta.
Nel documento INAIL, infatti, la parte “specifica” manca per definizione, essendo un documento standardizzato.
Eppure, per il DPCM è una misura sufficiente. E’ un difetto di tutela?
A nostro avviso no.
Si deve dedurlo dal solo fatto, che per le pubbliche amministrazioni perfino l’obbligo di informativa standardizzata INAIL viene escluso.
Inoltre, quello che risulta evidente è che, nel contesto emergenziale, il Governo ha ritenuto assorbiti nel documento INAIL tutti gli incombenti: INAIL ha naturalmente dovuto compiere una valutazione dei rischi per redigere una informativa su di essi, e poiché si tratta di rischi tipici della prestazione “fuori sede”, sono suscettibili di una standardizzazione che non è, per una volta, sinonimo di “copia e incolla”, bensì riconoscimento di una omogeneità di situazioni tutte tra loro assimilabili.
Ne consegue, che in questo contesto emergenziale il datore di lavoro che ricorre all’informativa INAIL ha adempiuto sia all’obbligo di informativa di cui all’art. 22 del Decreto 81/17, sia in generale agli obblighi sanciti dal Decreto 81/08; e questo per l’intero periodo dell’emergenza.
Del resto, sarebbe paradossale immaginare una contestazione al datore di lavoro di non avere valutato il rischio e adeguato il DVR, quando i rischi su cui informare i lavoratori sono indicati dallo stesso Governo mediante rimando ad INAIL e quando è di quei rischi che il datore di lavoro deve dare l’informativa.
La circostanza emergenziale è semmai l’occasione per interrogarsi sulla reale consistenza sostanziale dell’obbligo di informativa sui “rischi specifici” anche nel contesto del lavoro agile “normale”, quello che prescinde dall’emergenza Coronavirus: è l’occasione per domandarsi se la categoria dei “rischi specifici” riguardi non tanto lo svolgimento di lavoro agile in sé, quanto e tutt’al più gli effetti che esso comporta nelle dinamiche intra-aziendali e quindi, in ultima analisi, essenzialmente i profili di natura psico-sociale.
Tornando al tema di fondo, il punto è che possiamo (dobbiamo?) dare per scontato che ogni datore di lavoro privato trasmetterà al lavoratore l’informativa INAIL tal quale; e l’ulteriore punto è che nessuno potrà un domani lamentare che ciò non sia sufficiente per ritenere adempiuto l’obbligo di cui all’art. 22 della Legge n. 81/17.
Il dato letterale potrebbe essere forzato a questo proposito, se questo qualcuno sostenesse che l’art. 2 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020 consente sì di “ricorrere alla documentazione resa disponibile”, ma non afferma che essa sia sufficiente; in altre parole, si tratterebbe di una base di partenza, non di una informativa finita.
Per quanto possiamo essere abituati ad un sistema che (purtroppo) legge le misure di cautela a posteriori per trarne motivo di responsabilità, la tesi non appare davvero sostenibile.
Quella messa a disposizione da INAIL è, a tutti gli effetti, una “informativa”; ed il tenore letterale del DPCM è chiaro nel senso che tale documentazione costituisce lo strumento per adempiere all’obbligo.
Vero è semmai, che l’informativa INAIL contiene fin troppe cose, per uno “Smart Working da Coronavirus”.
Se in realtà si tratta di Home Working, sono sostanzialmente ultronei i paragrafi sui rischi negli ambienti outdoor, ad esempio; così come la tabella finale, riepilogativa di diversi scenari lavorativi possibili, tendenzialmente include un solo scenario davvero compatibile con il DPCM, e cioè quello del “lavoro agile in locali privati al chiuso”.
Ma non è certo il caso di stralciarli dall’informativa per un qualche amor di precisione; semplicemente sono parti dell’informativa che non troveranno applicazione in questa specifica fase storica.
Un’altra considerazione che la natura standardizzata dell’informativa INAIL porta con sé riguarda il fatto che, mentre la sottoscrizione da parte del lavoratore (che il modello INAIL prevede) è adempimento necessario per attestare l’assolvimento dell’obbligo, appare meno giustificata la firma del RLS, richiesta dal modello ai fini di una “condivisione del contenuto” che si dovrebbe ritenere superflua, essendo un documento di provenienza istituzionale riconosciuto nella sua efficacia dallo stesso DPCM. Naturalmente, bene farà il datore di lavoro ad acquisire tale sottoscrizione quantomeno per adesione formale al modello; ma non sembra che questa firma possa avere la valenza e l’efficacia di altri casi di coinvolgimento del RLS, né che la sua mancanza possa avere rilevanza sostanziale.
Anche in questo caso, la circostanza della deroga all’obbligo di informativa per le pubbliche amministrazioni non fa che confermare questa conclusione.
Da ultimo, è interessante osservare che la informativa INAIL richiama nelle “Avvertenze generali” sia l’art, 22 della Legge n. 81/17, sia l’art. 20 del Decreto n. 81/08.
L’art. 22 subito dopo la regola dell’informativa scritta sancisce l’obbligo del lavoratore di “cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
Se tale obbligo si riducesse all’obbligo del lavoratore di rispettare le misure di sicurezza, esso non sarebbe che un inutile doppione di quanto già previsto dall’art. 20 del Decreto n. 81/08. Il significato dell’obbligo di cooperazione è ben più profondo, e si ricollega intimamente alla circostanza dell’esecuzione della prestazione “all’esterno”, cioè in un luogo sottratto per definizione da qualsiasi ambito di intervento del datore di lavoro.
Il legislatore sancisce l’esistenza di un generale obbligo del lavoratore agile, in cui si compenetrano entrambe le norme, e questo obbligo è basato sulla centralità del ruolo del lavoratore agile, ai fini della propria sicurezza, quando si trova al di fuori dell’azienda; spetta al lavoratore agile applicare le misure di sicurezza, ma non in una prospettiva rigorosamente e ciecamente gerarchica tra obbligato-controllato e controllore, bensì in una logica di cooperazione.
Questa logica di cooperazione è tanto più significativa, quando l’abitazione è il luogo in cui si svolge l’attività, e dove trovano attuazione i principi di elevata autonomia, di capacità decisionale, di responsabilizzazione del lavoratore, che costituiscono il significato più profondo del lavoro agile; anche, e forse a maggior ragione, quando è Smart Working per Coronavirus.